Pensavo di dare il via a questo nuovo progetto con un essay luminoso, intenso ma fondamentalmente in chiave di Sol. In particolare pensavo di scrivere un essay sul piacere, su come questi due anni – quanto una guerra, quanto un terzo della vita di un bambino di prima elementare – ci abbiano man mano privato di tutto quello che nella vita ci dà piacere, qualsiasi cosa noi sceglievamo, consciamente o inconsciamente, per vivere una vita il quanto più possibile ricca anche di gioia e piacevolezza.
Però c’è un altro argomento che continua a pressarmi ed è tornato regolarmente nel mio orizzonte di questi mesi – da quando ho annunciato questa newsletter a oggi, che mi metto a scrivere. Parlare di piacere mi sembrava in qualche modo forzato: sarebbe un guardare avanti, legittimo nelle intenzioni e assolutamente meritato, ma ancora difficile, un’ennesima prestazione che pretendiamo da noi stessi. Ecco, hanno riaperto i cinema, via libera al piacere intellettuale. Posso prendere un aereo, oh ecco la gioia di viaggiare, proprio come la ricordavo. In realtà niente è come ricordiamo, soprattutto la nostra reazione alle cose che ci piacevano. E siamo ancora in una terra di mezzo, in convalescenza, forzati in fondo a chiederci chi siamo, ma privati della lucidità mentale di poter dare una risposta.
In questa terra di mezzo, fuori dall’emergenza ma lontani dalla ricostruzione, più che altro facciamo bilanci, spesso impietosi, sullo stato delle cose nella nostra vita, e chiusi nel nostro micromondo – un mondo fatto più stretto, di amicizie che ci vantiamo essere rimaste in poche, “solo quelle vere” (ma che male c’era in tutta la gente che vedevamo solo per l’aperitivo? Non contribuivano anche loro, nel loro modo, alla nostra preziosa rete sociale, più variegata e quindi più civile?) – dunque chiusi nel nostro mondo stretto di famiglia e amici, di vacanze in Italia e gite regionali che siamo costretti ad apprezzare, guardiamo noi stessi e attraverso i social guardiamo gli altri, ognuno nel suo micromondo; micromondi in esposizione ma non più in comunicazione (ci vestiamo con la tuta anche per uscire, non dobbiamo più fare bella figura, anche la più superficiale comunicazione visiva di corpi tramite la moda è arretrata).
Prima del piacere, pur continuando a cercarlo, come posso, vorrei parlare del fallimento, dello stare fermi mentre gli altri vanno, dell’andare nei posti sbagliati e del non essere mai perfettamente, furbamente, nello spirito del tempo.
Quest’estate ero in una cabina del cottage sul Baltico, tutti voi ormai la conoscete bene fino alla noia, questa in particolare è una stanza di legno con un letto e una scrivania, alcuni mobili buttati lì più per magazzino che per intenzionalità (una toletta, con uno specchio, e una tv attaccata al muro) e una vista sul mare che più che altro sembra un lago, melmoso come tutti i laghi, a volte visitato da uno strano batterio che causa sfoghi cutanei e va riconosciuto prima di immergersi. Quest’estate, o almeno quel giorno, faceva un caldo opprimente, non caratteristico per la latitudine, che attirava zanzare a sciami e mi faceva pensare al cambiamento climatico, alla fine di tutto, e alla mancanza di alternative (le mosche, esasperate, cozzavano rumorosamente contro ogni finestra, senza sosta, cercare di farle uscire, o ucciderle, un esercizio futile quanto scacciare dalla pelle le zanzare). Dico questo non per dare l’idea di un posto brutto – non lo è, affatto – ma per rendere conto dello stato d’animo in cui mi trovavo, e per avere uno sconto sulle cose che ho cominciato a fare e pensare, e per questo devo anche dire che è un posto da cui non ci si può muovere, circondato dal nulla del bosco per chilometri, 30km dal primo piccolo centro che di per sé non ha niente, se non un porto, un supermercato, un caffè e qualche altro servizio di necessità come la posta. Quel posto è la cosa più vicina nella vita reale a un ritiro, solo che non è allietato dallo yoga e dalle mille attività che si organizzano nei ritiri spirituali, è solo una casa, con tutte le comodità, sul mare-lago.
Dunque mentre stavo lì e lavoravo alle mie cose, lavoravo anche al sito web del mio fidanzato, un compito per cui mi ero offerta e che ho anche finito, e che prevedeva – come faccio sempre in questi casi – che guardassi anche alla concorrenza, ovvero alle persone che facendo il suo lavoro avevano un sito web. Non ho bisogno di questa elaborata spiegazione per dire che sono andata a vedere cosa faceva la sua ex – perché a volte vado a fare un giro sui social senza un motivo, solo per curiosità, o tutti i sentimenti che per sintesi nascondiamo dietro alla parola curiosità – ma in questo caso sono dovuta andare proprio sul sito, e qui arriviamo a come avrei dovuto iniziare questo essay: la ex del mio fidanzato fa la professoressa alla London School of Economics. Sarebbe stato meglio, e anche come titolo non è niente male. Dunque questa donna da dieci anni studia la prostituzione, il modello nordico o meglio il suo fallimento, i flussi migratori e i diritti dei sex worker. Lo fa sul campo, avendo intervistato centinaia e centinaia di sex worker, in posti sordidi e pericolosi, e manifestando, attivando, ma non l’attivista da social, proprio l’attivista da strada, insomma case chiuse, strade di notte, a Oslo, a Stoccolma, a New York, cose da Millennium Trilogy, praticamente una corrispondente di guerra. Tutto questo, leggo dal sito, l’ha portata a essere citata da vari quotidiani, a pubblicare una sfilza di testi, a ottenere un posto, infine, alla London School of Economics. Di questa storia mi colpiscono tre cose: che il duro lavoro ripaga; che il lavoro che paga è concepito soprattutto come costanza e monodirezionalità; che è più facile fare il duro lavoro che ripaga se ti pagano per farlo, nel senso se hai, dal primo giorno di università all’ultimo giorno di dottorato, un piccolo stipendio (che man mano diventa un vero stipendio) per occuparti di nient’altro che quello che stai facendo: nessun lavoretto estivo, niente ripetizioni da dare, niente baby-sitting, niente, infine, di certi testi che scrivo per i siti web, per la pubblicità e per lo storytelling volto al commercio, al guadagno e alla manutenzione della nostra particolare, italica funamboleria (essere creativi e guadagnare, l’alto e il basso, il puro e l’impuro, il lavoro aulico e il lavoro di cui dovremmo vergognarci).
Loro (gli abitanti del Nord Europa), grazie allo Stato, sono esseri puri. Guardo il mio fidanzato e vedo questo perfetto senso di entitlement (una forma più mite di supponenza), ovvero che tutto quello che ha ottenuto se l’è guadagnato, meritato, e penso: questa retorica del fallimento e del successo come faccende individuali, come abbiamo fatto a cascarci per tanti anni, come abbiamo fatto a crederci? Come abbiamo fatto a crederci tanto importanti. Forse perché nessuno di noi si confronta direttamente con il privilegio altrui. Ognuno ha il proprio, e tutti noi insieme, come paese, ci stiamo abituando allo sgretolarsi del privilegio: l’assenza di tutela del lavoro, l’assenza di scelta, l’assenza di reti di salvataggio economiche.
Simone de Beauvoir, nel suo fondante “Il secondo sesso”, scrive riguardo alle ragazze: “La ragione profonda di tale disfattismo [riguardo alle proprie capacità] è che la adolescente non si considera responsabile del proprio avvenire; giudica infantile pretendere troppo da sé stessa perché in definitiva non toccherà a lei decidere il proprio destino”. Mi sembra che questo sia il sentimento che abbiamo condiviso e sempre di più condividiamo, ragazze e ragazzi, ovviamente in misura diversa ma lo stesso sentimento, nel nostro paese. Quale maestra in buona fede poteva dirci: impegnati in qualcosa in modo incondizionato, e avrai successo? E quelle che l’hanno fatto, non hanno dimostrato di mentire, tanto che, ancora traumatizzati, come generazione ce la prendiamo con chi ha osato, in quei giorni di scuola di anni ’90 e 2000, darci un po’ di speranza? Non era poi dato per scontato ai tempi che, se avessimo studiato materie umanistiche, saremmo finiti disoccupati? E con che morso si può restare attaccati alle proprie ambizioni, che dopo l’immediata gioventù appaiono irrealizzabili?
Credo che N., la ex, non sia una persona straordinaria. Non lo dico perché ne sono gelosa, sono semmai invidiosa: invidio il clima di sicurezza in cui è nata, che ha permesso alla scuola di dirle: vai, segui il tuo interesse, potrai passare 6 anni a intervistare prostitute e quello, se lo vorrai, sarà il tuo lavoro. Se non riuscirà a essere quello il tuo lavoro, ne troverai un altro. Easy. Non c’è ragione di stressarsi. Eliminato tutto il rumore, il telegiornale che parla di corruzione, il senso di dover essere raccomandato, o almeno entrare, per qualche merito obliquo, in una cricca; il favore del barone da guadagnarsi, quello della casta intellettuale. E poi i lavori, mille lavori, a meno di non volersi abbandonare completamente alla famiglia, chi ne ha una che può sostenere tali ambizioni, ma con il ricatto che sempre, per quanto lieve, ne consegue, dal punto di vista personale e morale, con le sue conseguenze sulla stima di sé.
Molti anni fa, a un premio letterario che ora non esiste più (lo sottolineo perché era un premio in denaro), incontrai un’autrice che mi disse, anzi spiegò al tavolo, “io non faccio niente”. Era chiaramente un dire che non aveva bisogno di lavorare, ma tradiva anche una profonda convinzione che quello che faceva – scrivere, con buoni risultati – non fosse lavoro.
Torno da Simone de Beauvoir per snaturare un’altra sua frase, e attribuirla a qualcos’altro: “la madre è sordidamente ostile alla libertà della figlia e, più o meno palesemente, fa di tutto per tormentarla”. Mi perdonerà chi riconduce al termine patria attributi maschili, ma mi sembra questo proprio quello che fa l’Italia con noi, i suoi giovani non-più-giovanissimi: la madre ostile, che non rispetta il nostro sforzo per emanciparci dallo stato di giovani, e lo fa per sciatteria morale, per pigrizia, per corruzione e per incapacità. Siamo tutte figlie femmine in Italia, scoraggiate da ogni iniziativa, dall’intraprendere “una lunga gita, un viaggio a piedi e in bicicletta o dedicarsi ai giochi”.
Postilla:
Questa newsletter ha la forma di long read, ovvero un articolo lungo di creative nonfiction (o narrative journalism): se uso queste parole è perché non ne abbiamo di nostre, e non mi risulta che questa forma sia presente nelle testate in lingua italiana – sicuramente mi sbaglierò, per correggermi (o per qualsiasi considerazione) potete semplicemente rispondere a questa mail.
La cadenza sarà mensile o trimestrale, in ogni caso non intaserò la vostra mail.
Nella postilla metterò dei riferimenti esterni; in questo caso segnalo:
Il secondo sesso, Simone de Beauvoir, nell’edizione Il Saggiatore, pubblicato per la prima volta nel 1949 (ah, la Francia), in Italia nel 1961. 715 pagine, costa 26€. Al momento in cui scrivo Carolina Capria aka @lhascrittounafemmina ne sta facendo una lettura con il suo bookclub, aperto a tutti.
Il magico potere del fallimento. Perché la sconfitta ci rende liberi, Charles Pépin, Garzanti, 2017. 176 pagine, 15€. Scritto da un filosofo francese (ah, la Francia), è uno dei tanti testi che cercano di riabilitare il fallimento, anche se io personalmente vorrei una società che ci mettesse nelle condizioni di fallire di meno – set us up for success – e non che normalizzasse il nostro continuo fallire.
L’arte di sbagliare alla grande. Enrico Galiano, Garzanti 2020. Insegnante delle scuole medie, comunicatore (anche sui social).
Il museo del fallimento (MOX): lo riporto solo perché quando parlo di fallimento me lo ricordano sempre. È in Svezia, ha aperto nel 2017, e mostra una collezione di prodotti flop, che non sono andati bene sul mercato, e dovrebbe indicarci che anche i grandi (Coca cola) sbagliano, quindi siamo a posto così.
Quasi tutti i film hanno protagonisti che almeno all’inizio sono dei perfetti falliti, alcuni anche meschini e invidiosi. Visto che ho parlato di nord Europa, segnalo un film danese in cui il fallimento – il suo spettro, o la sua allegra accettazione – è un tema laterale, un film bellissimo e per quanto mi riguarda un perfetto successo (infatti ha vinto l’Oscar come miglior film straniero nel 2021):
Un altro giro (Druk), di Thomas Vinterberg, 2021, con Mads Mikkelsen (un attore appropriato dalla serie tv americana Hannibal che qui è libero, alla sua migliore performance).










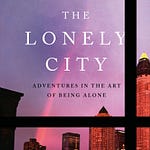

#1 Sul piacere anzi, sul fallimento